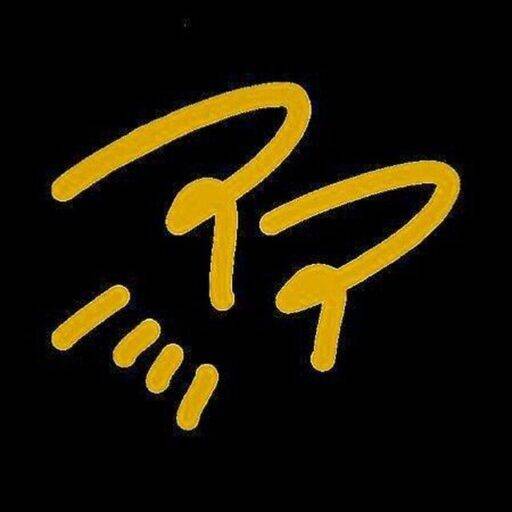Letture novecentesche di Spinoza: Gilles Deleuze (12)
Come è noto, la concezione di Baruch Spinoza (1632-1677) secondo cui esiste una sola sostanza infinita e non esistono sostanze finite pone il problema dell’esistenza di enti ontologicamente finiti distinti da tale unica sostanza. Nell’assai denso capitolo del saggio di Gilles Deleuze Spinoza et le problème de l’expression (1968, tr. it. Spinoza e il problema …
Leggi tutto “Letture novecentesche di Spinoza: Gilles Deleuze (12)”