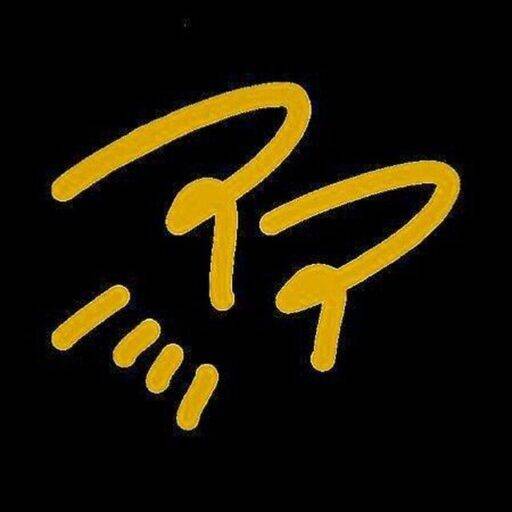La volontà di questa “saga”, divisa in tre episodi, è quella di parlare della discendenza hegeliana. Non mi soffermerò sul personaggio in sé, perché non ha bisogno certamente di presentazioni. Dirò solamente che ci troviamo di fronte ad un vero e proprio gigante, un autore che ha lasciato il segno, dalla sua epoca fino ai giorni nostri.
La sua eredità è preziosa e fruttuosa, un ostacolo inaggirabile pari al pensiero di ad esempio Platone o Aristotele. Non a caso si parla sempre di un “prima ed un dopo Hegel”.
Parlare dell’hegelismo, in generale e dei vari suoi interpreti, richiede veramente molto tempo. Proprio per questo motivo ho scelto tre autori per tracciare un percorso che va dalla fine dell’ottocento fino alla contemporaneità: August Cieszkowski, Alexandre Kojève e Jacques Lacan.
Tre personalità diverse di epoche diverse, che a modo loro hanno reinterpretato e attualizzato il pensiero del filosofo tedesco.
Dopo la scomparsa di Hegel, avvenuta nel 1831, si avviò immediatamente una riflessione speculativa sul suo insegnamento che, soprattutto nel campo del pensiero politico-religioso, conobbe sviluppi ed evoluzioni significativi. Questi sviluppi non portarono a una soluzione o posizione univoca, ma si tradussero in teorie spesso contrastanti. Gli orientamenti che emersero all’interno del sistema hegeliano vennero distinti, per tradizione, in una destra, rappresentata dai “conservatori”, e una sinistra, interpretata dai “progressisti”. Ovviamente, questa dicotomia non deve trarre in inganno e suggerire un indirizzo politico in senso stretto, ma piuttosto mostrare una certa continuità o superamento del pensiero del filosofo.
Queste due fazioni non erano così nette come si potrebbe pensare; infatti, troviamo anche figure più sfumate, come quella del filosofo polacco August von Cieszkowski (1814-1894), conosciuto soprattutto come autore dei Prolegomeni alla Storiosofia, testo che influenzò notevolmente il pensiero del giovane Karl Marx. Il suo pensiero, infatti, è incentrato sul futuro nella storia e nella filosofia. Pubblicata nel 1838, l’opera introduce una riflessione molto importante nel dibattito filosofico dell’epoca: si interroga sulla possibilità di applicare la dialettica hegeliana non solo temporalmente al passato e al presente, ma soprattutto al futuro, all’avvenire. La questione, quindi, ruota attorno alla possibilità per lo Spirito, per la conoscenza filosofica, di non fermarsi al presente, ma di essere applicabile al futuro. In questo testo troviamo anche l’influenza del pensiero di un altro celebre pensatore tedesco, Johann Gottlieb Fichte, il quale contrappone all’essere del presente il dover essere dell’avvenire, che può essere realizzato solo dall’azione.
Saranno proprio i Prolegomeni a gettare le basi del carattere rivoluzionario del pensiero marxiano: se la filosofia è la ricerca del vero, è applicabile solo al passato e al presente oppure anche al futuro? Per Cieszkowski la risposta è affermativa, a patto che alla dialettica si dia una dimensione integrale. Non solo, quindi, dal punto di vista conoscitivo, ma anche pratico, ovvero che si applichi al futuro in quanto essa stessa cerca di costruire il proprio futuro. Il pensiero hegeliano, a suo modo di vedere, cerca di conciliare l’Eterno e il Tempo, ma non tiene conto del futuro. Con questa nuova tensione, teoria e pratica diventano un unicum: se la dialettica è rivolta al futuro, allora il discorso sulla verità non è solo di carattere teoretico/gnoseologico, ma ha anche una “ragion pratica”. A partire da Cieszkowski, i giovani hegeliani iniziano a mettere in discussione la concezione hegeliana della filosofia della storia e il ruolo della filosofia rispetto alla realtà. La filosofia non doveva più limitarsi a concettualizzare il reale, ma doveva diventare pratica, agendo nella realtà e potenziando la vita.
La metafora della “nottola di Minerva”, che vedeva la filosofia come una riflessione a posteriori sulla realtà, viene ritenuta inadeguata. I giovani hegeliani propongono invece una filosofia orientata al futuro, capace di trasformare il presente in funzione della libertà. Il problema di Hegel, secondo loro, non era tanto la priorità data al tempo sullo spazio, quanto l’aver “compresso” il tempo nel presente, rischiando di concludere la storia con il sistema filosofico. L’epoca futura sarebbe stata determinata dalla praxis, con la filosofia che agiva attraverso la volontà.
Ed è così che autori come Feuerbach, Cieszkowski, Hess, Ruge, Bauer e il giovane Marx, ispirati da Fichte e da Cieszkowski stesso, propongono di trasformare la massima hegeliana “ciò che è razionale è reale” nell’imperativo “ciò che è razionale si deve fare reale”. La filosofia deve intervenire nel mondo, non limitarsi a validarlo, assumendo il reale come sempre da riprogettare.
Non a caso, nel 1845, Karl Marx scriverà nella undicesima tesi su Feuerbach “[finora] i filosofi hanno solo interpretato diversamente il mondo in vari modi; ma si tratta di trasformarlo”.
L’articolo è soggetto a Copyright© secondo la Legge 22.04.1941 n. 633 (Legge sulla protezione del diritto d’autore), per maggiori informazioni consultare Termini e condizioni.