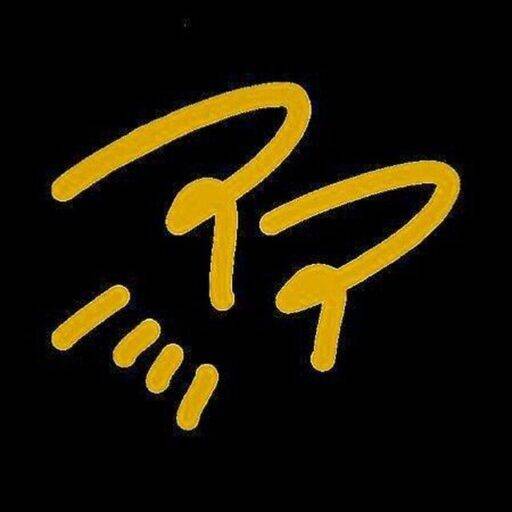Quando possiamo dire che un’idea è vera? Nel saggio Spinoza et le problème de l’expression (1968, tr. it. Spinoza e il problema dell’espressione, Quodlibet, Macerata, 1999), Gilles Deleuze (1925-1995) risponde distinguendo la verità dell’idea, che attiene alla sua forma, dall’adeguatezza dell’idea, che attiene al suo contenuto. L’idea vera, dal punto di vista della forma, è l’idea dell’idea; dal punto del visto della materia, l’idea è vera quando è adeguata. Come l’idea dell’idea (io posso avere un’idea di una certa cosa, che è diversa dall’idea dell’idea di quella cosa) costituisce l’idea riflessiva, così l’idea adeguata costituisce l’idea espressiva. In Baruch Spinoza (1632-1677), il termine “adeguato” non indica la corrispondenza dell’idea con l’oggetto che essa rappresenta o designa, ma la convenienza interna dell’idea con quello che essa esprime. Ma cosa esprime l’idea? Essa deve esprimere la sua causa e quindi implicarne la conoscenza. L’idea adeguata è l’idea che esprime la sua causa (cit, p. 105). Il metodo di Spinoza per la conoscenza delle idee si articola, quindi, in tre gradi. I. Il primo grado riguarda il fine del pensiero che, non consiste tanto nell’apprendere qualcosa, quanto nel conoscere la nostra potenza di conoscere. La definizione formale della verità è la seguente: l’idea vera è l’idea in quanto si esplica attraverso la nostra potenza di conoscere. Il metodo sotto tale aspetto è riflessivo. II. Il secondo grado del metodo riguarda il mezzo per raggiungere questo fine. Occorre rendere adeguata questa idea che si presuppone vera. Essa diventa adeguata se esprime la propria causa e in quanto esprime l’essenza di Dio che determina tale causa. Il metodo secondo tale aspetto è espressivo. III. Il terzo grado attiene all’unità di fine e mezzo. Fra l’idea e l’idea dell’idea vi è solo una distinzione di ragione: l’idea riflessiva e l’idea espressiva sono in realtà la stessa cosa. Ma come deve essere intesa questa unità? Deleuze sintetizza così: un’idea vera non ha mai come causa l’oggetto che rappresenta, ma rappresenta un’oggetto perché esprime la sua causa (cit., p. 110). Vi è quindi un contenuto dell’idea, un contenuto espressivo e non rappresentativo, che rimanda soltanto alla potenza di pensare; ma la potenza di pensare è ciò che costituisce la forma dell’idea in quanto tale. L’unità concreta di entrambi si manifesta allorché tutte le idee di deducono le une dalle altre, materialmente a partire dall’idea di Dio, formalmente sotto la potenza di pensare. Da questo punto di vista il metodo è deduttivo; la forma, come forma logica, e il contenuto, come contenuto espressivo, si riuniscono nella concatenazione delle idee. Spinoza dice che la nostra mente è una sorta di automa spirituale; in altri termini, quando pensiamo, obbediamo solo alle leggi del pensiero, leggi che determinano nello stesso tempo la forma e il contenuto dell’idea vera, che ci fanno concatenare le idee secondo le loro cause e secondo la nostra potenza, benché non si conosca la nostra potenza di conoscere se non conoscendo, attraverso le cause, tutte le cose che cadono sotto questa stessa potenza. Pochi filosofi hanno attribuito, come ha fatto Spinoza, una così profonda nobiltà al pensiero quale facoltà dell’essere umano. In tempi di trionfo dell’emozione come mezzo del conoscere propalato in ogni dove, dovremmo ricordarci che è invece il pensiero il fine e il mezzo del conoscere.
L’articolo è soggetto a Copyright© secondo la Legge 22.04.1941 n. 633 (Legge sulla protezione del diritto d’autore), per maggiori informazioni consultare Termini e condizioni.