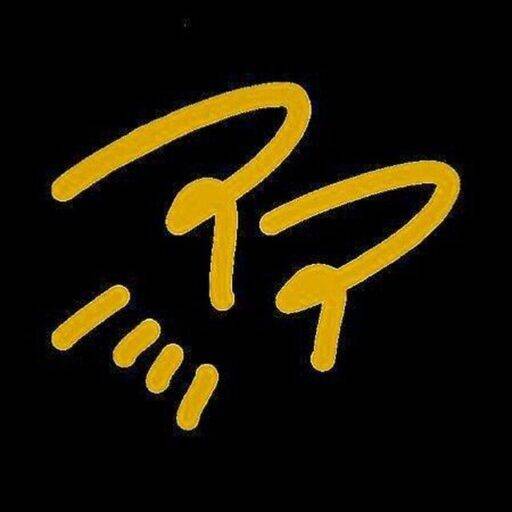Gilles Deleuze nel capitolo quattordicesimo del suo saggio Spinoza et le problème de l’expression (1968, tr. it. Spinoza e il problema dell’espressione, Quodlibet, Macerata, 1999) afferma che la triade espressiva del modo finito spinoziano (concetto essenziale del suo pensiero in grado di scardinarne l’accusa di panteismo) si presenta in questi termini: (i) l’essenza come grado di potenza; (ii) il rapporto specifico nel quale si esprime; (iii) le parti estensive sussunte sotto questo rapporto e che compongono l’esistenza del modo. Nell’Ethica, tuttavia, secondo Deleuze un serrato sistema di equivalenze conduce ad una seconda triade del modo finito: (i) l’essenza come grado di potenza: (ii) una capacità del modo di essere affetto nella quale l’essenza si esprime; (iii) le affezioni che in qualunque momento colmano tale capacità. E’ questa capacità che permette a Spinoza di “differenziare” i singoli enti dall’unica sostanza. L’esistenza del modo è la sua capacità di essere affetto, per cui ciò che lo distingue da un altro modo è il fatto che può essere affetto da cose diverse da quelle da cui l’altro modo è affetto. Perché un corpo esista quindi deve essere affetto da qualcosa. Per Spinoza la struttura del corpo e le sue affezioni sono un tutt’uno. Spinoza può così considerare equivalenti due domande fondamentali: Qual è la struttura (fabbrica) di un corpo? Cosa può un corpo? Questo passaggio è fondamentale per capire l’idea modernissima della corporeità degli individui che ha Spinoza. Bisogna inoltre rilevare che l’affezione del modo finito è sempre causata da un’azione di modi ad esso esterni. Ciò non accade in Dio, perché Dio è causa di tutte le sue affezioni e quindi non può patirne. Per capire questo punto, occorre non fare confusione tra affezione e passione. Un’affezione è una passione solo quando non si esplica mediante la natura del corpo affetto: essa implica senza dubbio tale natura, ma si esplica mediante l’influenza di altri corpi. Le affezioni che si esplicano interamente mediante la natura del corpo affetto sono azioni. Questo comporta che per i modi esistenti le affezioni sono prima di tutto passioni. Ma un modo finito può avere allora affezioni attive? E in che modo? Questa è la vera e propria domanda “etica”. Infatti, l’etica nasce proprio dalla nostra possibilità di non esser solo soggetti di affezioni passive. Spinoza introduce quindi un altro concetto: quello di affetto. Quest’ultimo è l’idea di affezione che indica la costituzione del nostro corpo congiunta all’idea del rapporto fra questa presente costituzione e quella passata. I nostri affetti, in sé, sono idee che implicano il rapporto fra il presente e il passato, secondi una durata continua. Questa capacità del corpo di essere colmata da affezioni passive ha il suo equivalente nella potenza della mente di immaginare e provare affetti passivi. Qualunque sia la proporzione tra le affezioni passive e le affezioni attive, la capacità di essere affetti rimane costante, mentre la potenza di agire e la potenza di patire sono due potenze che variano in maniera correlativa. Ma la nostra forza di patire è un’imperfezione in quanto è il limite della nostra forza di agire. La nostra forza di patire non afferma nulla, perché non esprime nulla: “implica” solo la nostra impotenza, ossia la limitazione della nostra potenza di agire. Per questo Spinoza dice che non sappiamo neanche di quali affezioni siamo capaci, non sappiamo fin dove arrivi la nostra potenza.
L’articolo è soggetto a Copyright© secondo la Legge 22.04.1941 n. 633 (Legge sulla protezione del diritto d’autore), per maggiori informazioni consultare Termini e condizioni.